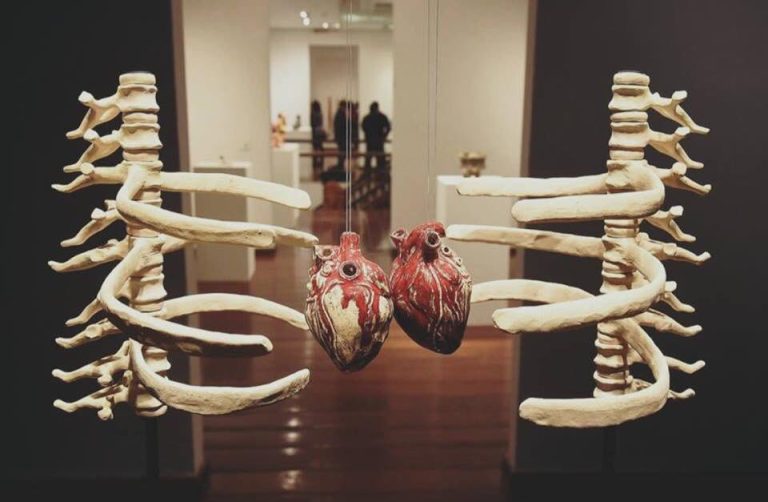Pubblichiamo la prefazione di Giusi Drago a Narrazioni.
*
Nelle Narrazioni di Rotino, che sono in realtà metanarrazioni, si mescolano favole moderne e antiche, paure antiche e moderne, su un fondo inesorabilmente nero. Domina infatti in queste poesie una oscurità del dire che nasce dalla consapevolezza di quanto la lingua sia invischiata nella “melassa del nero” e da esso sporcata: “ogni parola è cosa ogni cosa è detta nell’ombra sta aspetta e appena la maledetta cade fuori /
dalla nostra bocca imperfetta ci culla afferra il nostro peso”.
Nei versi lunghi, extra-large, che producono un effetto ansiogeno sia per l’assenza di punteggiatura sia perché sembrano non finire mai, tanto sono eccedenti rispetto al fiato, si formano “pozze di saliva nera” e nel cerchio di stagnazione di queste pozze le parole affondano insieme al loro senso, dato che intrattengono rapporti ambigui con la realtà e non hanno dove ancorarsi. Più precisamente, e con una rima che è quasi un bisticcio, la dialettica è fra il “vero” e il “nero”. Nella poesia che apre la raccolta i due termini stanno in tensione fra loro grazie alla mediazione di un “vero coraggio” che “per quanto nero” appare “sincero nel moto della menzogna”. Una qualche forma di vita vera resiste, “pur calata / dentro il nero colore gli aggiunge valore ogni tanto ci rende leggeri dentro il nero affondati coscienti del vero incoscienti”.
Il lato tenebroso si manifesta innanzitutto nella forza ossimorica di quel velo d’ignoranza che ci rende coscienti/incoscienti e agisce oscurando i rapporti della parola poetica con il vero e con l’intero (per dirla con Hegel). Ma ancor più emerge nella presa di distanza, nel necessario distacco dal reale da cui questi versi scaturiscono. Emblematica al riguardo è la poesia teca: la teca in questione è sia quella in cui è
custodita Biancaneve, sospesa fra vita e morte, sia la bottiglia di vetro che contiene la città di Kandor, miniaturizzata da Brainiac, nemico di Superman, qui citato col nome originale di Kal-el. Si tratta di una Biancaneve lanciata nello spazio o di un Superman trasformato in principe azzurro con manie necrofile da collezionista (“incartata al meglio albina chiusa nella teca a mo’ di perfezione statica di morta estetica”).
Rotino è abile nel confondere temi e motivi delle due mitologie sino a produrre un vivificante effetto di straniamento, che del resto viene ottenuto anche con l’uso del verso lunghissimo e con gli a capo forzati. Per giunta, il principe azzurro al momento opportuno si ritrae “dall’ammirare il contenuto, dal baciare quelle forme per apprezzare il contenente”. Un prence postmoderno che a conti fatti preferisce fermarsi a contemplare la teca trasparente e non ha alcuna intenzione di violare lo spazio preservato dall’involucro.
La teca insomma è un filtro distanziante che consente, grazie alle sue funzioni protettive, di non entrare in contatto urticante-deludente con una realtà frantumata e magmatica. Lo stare a distanza, l’essere lontano, o – se vicino – separato da una sottile parete di vetro trasparente o plexiglas appare una condizione necessaria a “preservare la bellezza come il vuoto del tuo star da solo nel freddo mausoleo nella fortezza”. Non c’è modo di arrivare alle cose stesse, né dentro la teca né fuori: se la teca custodisce al proprio interno “spazi senza fiato”, una vita che non “appare come vita”, un’esistenza preservata solo in quanto mummificata, all’esterno della teca si estende “il quieto splendore di ceneri ancora da venire” e “l’ombra dell’uomo diventata cieco muro”.
In una sezione del libro intitolata Distanze si comprende in che misura un eccesso di vicinanza si traduca in una luce abbagliante che finisce a propria volta per accecare: la luce del sole è “onnipresente” e insegue “da stanza luminosa a stanza luminosa” costruendo intorno all’inseguito “la prigione meravigliosa della realtà”, che “lo brucia lo acceca qualunque atto compia e se un attimo si fermasse per un attimo / si arrendesse alla sua ferocia naturale potrebbe forse riconoscerne la ragione quanto in essa ha valore la stanchezza il dolore di scegliere parole / già dette altrove da altri dette senza successo alcuno”.
Di esempi di “ferocia naturale” queste Narrazioni di Rotino abbondano: dalla voracità della strega divoratrice di bambini in rapsodia del piccolino al sorriso estatico della donna che appicca il fuoco ai libri “lasciando bruciare se stessa da santa” in 451, una sequenza felicemente ispirata a Fahrenheit 451, all’irrompere di uno squarcio di luce che come una lama “si apre strada strappa dolore a tagli a morsi”.
La “ferocia naturale” infatti è una qualità che unifica in una stretta appartenenza uomo e animale o uomo e manifestazioni naturali e ha il potere di trasferire immediatamente l’umano in una dimensione aliena e familiare al tempo stesso. Tale ferocia è un vettore di comunicazione con mondi altri, rappresentati da Rotino sia sotto le spoglie di capsule spaziali e di viaggi interstellari sia come esplorazioni all’interno della dimensione archetipica. La sua scrittura si riveste allora di significati utopici, appare come una ricerca di contatto – sempre fallita o sul punto di fallire – con una lingua appunto aliena o come il tentativo di sperimentare una nuova lingua comune, che sorga sulle ceneri delle precedenti rendendo possibile uno scambio. La citazione di Ted Chiang posta a esergo del libro lo conferma.
Così come la bellissima epifania di animale, descritta nella terza poesia della sezione Animalier: un muso di volpe che per un attimo erompe rossastro dal buio della selva. Singolare qui è che il breve mostrarsi dell’animale dia subito luogo a un rimprovero, rendendo evidente la colpa degli umani: quella di essere sempre troppo voyeur, perché l’osservatore muta la realtà e il guardare non è mai innocente (“l’errore // è quello di essersi fatti presente / così da tramutarti in un fruscìo // dopo / il nulla torna sei // persa per sempre”).
Se la volpe, per antica diffidenza, prende la via della fuga in modo da sfuggire alla violenza dei nostri sguardi, ha pur sempre commesso l’errore di esser vista, di essersi fatta “presente” a propria volta. In un’altra poesia, nel bosco, che trasfigura la fiaba di Hänsel e Gretel, l’animale suggella invece un’ambigua alleanza con la vittima: “il patto fra volpe e piccolino tra bestia e mingherlino / di chi l’altro mangiare può verso chi invece verrà mangiato”. Homo homini vulpes: le due apparizioni del medesimo animale alludono a un’antropologia negativa. Nella ferocia naturale, simboleggiata dalla volpe, infatti, il nero e il vero tornano a coincidere.