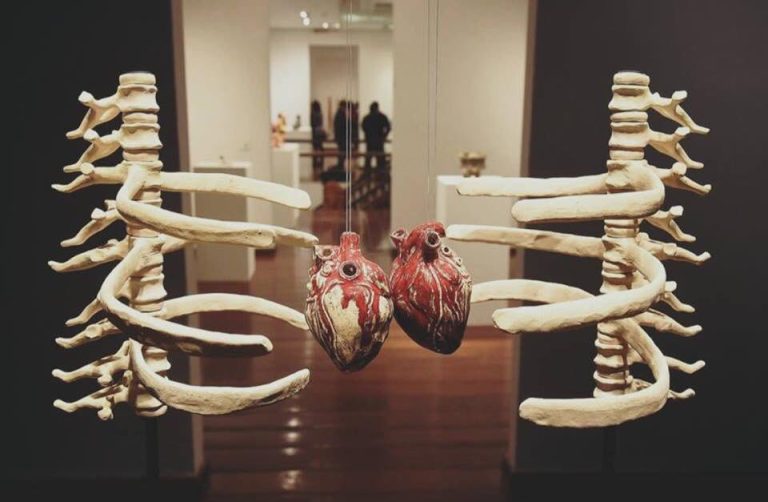Quest’ultima prova di Silvia Secco, pur nella continuità di temi e atmosfere con le raccolte precedenti, costituisce una svolta di ordine sperimentale e più precisamente drammatico, nel senso cioè di un testo predisposto a un’eventuale messa in scena.
A ciò sembrano preposti gli undici scenari o fondali di parole in cui è suddiviso, che si susseguono caleidoscopicamente con riprese e variazioni degli stessi temi: l’amore e la scrittura, la vita e la morte, in un costante parallelismo di testo e territorio, che ci trasporta in una serie di scavi “dietro il paesaggio”, secondo la lezione zanzottiana sicuramente appresa ed elaborata dall’autrice.
Tempo fa, scrivendo sulla poetica di Secco nelle sue tre opere precedenti, L’equilibrio della foglia in caduta, Canti di cicale e Amarene, avevo individuato una tensione fra due funzioni contrapposte: la funzione Zanzotto o formica, appunto, di scavo dentro il paesaggio, e quella De Angelis o cicala, di sorvolo e di ubiquità dell’istanza di enunciazione.[1] Ora queste due funzioni si fondono ed espandono in una versificazione che si allunga a sfiorare i limiti della prosa ritmica e ad esplorare gli anfratti, le crepe, le pieghe e le piaghe di un territorio vissuto e vivente, palpabile e palpitante, esposto alla siccità crescente e alle improvvise esondazioni, al variare delle stagioni e alle catastrofi inattese, che costituisce il correlativo oggettivo delle intermittenze del cuore e della memoria della poeta.
Della sua cura dei “morti di tutte le specie”: dai lari della casa agli annegati dell’alluvione del Vajont, dagli emigranti dispersi sulle vie del mare ai bambini non nati, in una esplorazione che si muove sulle soglie tra fattuale e possibile, con un particolare accento su ciò che poteva essere e non è stato e che si fissa nell’immagine del figlio mai nato, che condensa il tema della procreazione sia naturale che artistica. Un oscuro senso di colpa e una sorta di terrore per la sterilità del grembo e dell’immaginazione, traspaiono infatti in tutta l’opera precedente di Secco. Questo suo ultimo testo si sviluppa proprio attorno alla polarità secco/umido e all’ambivalenza dell’acqua come portatrice di vita e di morte, di nutrimento e di devastazione.
Della lezione di Zanzotto, dicevamo che costituisce nella nostra poetessa una sorta di ecologia della mente, aprendola a risonanze metafisiche e ad affondi paleontologici, assaggi del tempo profondo dell’evoluzione, nel parallelismo fra onto e filogenesi, e insomma conferendo a tratti un valore archetipico a certe vicende o scenari evocati. Ma se Zanzotto scava il terreno con la piccozza, Secco lo fa col cesello, nella sua squisita arte di miniaturista, e se Zanzotto esplora il bosco, Secco coltiva il suo giardino, con sapienti delicati innesti e potature, traendone poi pozioni magiche (come quel concentrato di “amarene” della raccolta precedente) che mettono in evidenza la funzione della scrittura come traccia, supplemento e farmaco della parola che non viene alle labbra o che non dura. Parola individuale o collettiva, flatus vocis universale, “canto di cicale”, radiazione cosmica di fondo, rumore bianco che rischia di disperdersi in impercettibili armonici.
Proprio sulla scorta di temi e schemi delle opere precedenti, si può dunque comprendere appieno la funzione di questi undici scenari di parole, predisposti a una performance vocale, magari accompagnata da un tappeto strumentale, continuo o intermittente poco importa. Si provi infatti a leggere questo testo col sottofondo del cantus firmus gregoriano, della monodia dell’ars antiqua, e credo si noterà la felicità dell’effetto. Perché questa drammaturgia sperimentale è in verità di ordine liturgico, sicché infatti, dopo tutta una serie di stacchi e variazioni, si compie con una preghiera panica e corale:
“Dio, / quasi sostanza, quasi palpabile. Dio, / esternotte e brina e fià de omini e fià/ de bestie e foje, e fià de acque e de le prie/ e dele giare de pria che se sfina in polvare, / e fià de vose de soete che siga, e fià de uno/ che cria, libera. Tu libera, libera nos.”
E con una domanda esistenziale che coinvolge i vivi e i morti: “I morti di tutte le specie, anche loro sono/ ciechi, anche loro si chiedono.” Di questa ritualità diffusa, si fanno carico la funzione De Angelis (anch’essa ormai felicemente appresa e messa a frutto) nel senso della volatilità e ubiquità dell’istanza di enunciazione, e soprattutto l’insistenza sulle ripetizioni parola per parola, spesso nella sovrapposizione fra lingua e dialetto alto vicentino, che costituisce il procedimento stilistico dominante di questa silloge, indicando l’orientamento genealogico della ricerca verso la lingua madre e l’Heimat, la casa dell’essere, il nido da costruire, curare, abitare:
“Madre – non ancora nata – del coraggio, / madre dignitosa di puro piangere del mare/ regina del reame dei giusti, miti fra i miti madre mia, / degli errori e dei rammendi, dei ricami sopra i guasti. / Se ti volti adesso che ti chiamo, / bruna madre bianca e franca, festeggiamo/ un compleanno come nessun altro, festeggiamo/ te bambina e te ragazza e te, linguamadre mia/ sposa e innamorata.”
Questo doppio registro mostra tra l’altro la faglia interna al linguaggio, la crepa madre da cui scaturisce la poesia come composizione di un luogo alternativo alla insopportabile realtà della guerra e della morte, dell’aridità e del diluvio, del disamore e dell’indifferenza. In quest’ultima raccolta, la poeta insiste molto infatti sulla necessità della “bugia poetica” come mezzo di esorcismo della morte e di “educazione estetica del genere umano” (Schiller). Un motivo ricorrente che culmina nel rituale apotropaico della scena IX:
“Ogni busia fata poesia…che saria un pecà mortae se’a fusse vera, ma un pecà/ sta fantasia de la mortalità.”
La liturgia, che si esplica attraverso ripetizioni quasi formulari, si condensa poi nelle cantilene e nelle filastrocche, “patrimonio cellulare” della memoria, che vengono introdotte fin dall’inizio nella nota dell’autrice. E che fra l’altro mettono a tema il costante parallelismo fra testo e territorio, scrittura e natura, che è un altro tratto saliente di questa raccolta:
“Ma le porte xe de fero, / volta la carta ghe xe un capelo:/ un capelo pien de piova, / volta la carta ghe xe una rosa.
Vari altri rilievi si potrebbero fare su questo testo fluido e liminare, moderatamente sperimentale, che si innesta però saldamente sul tronco della poetica dell’autrice, maturata nelle opere precedenti. Ma credo che quanto già detto possa bastare affinché il lettore poi trovi la propria strada nel testo.
Rimane da ribadire che tra “i morti di tutte le specie” di cui recita il titolo, primeggiano qui in non nati, coloro che sono rimasti intrappolati nella dimensione del possibile. Ma questo semplice rilievo ci trasporta nel fitto intreccio di radici dell’opera dell’autrice, nel sottobosco organico e vegetale dell’immaginario di questa driade dei boschi che da sempre ha avvertito il terrore della sterilità e il rimorso per essersi dedicata alla conta delle sillabe piuttosto che a quella delle settimane che precedono il parto. (Canto di Cicale). Così assistiamo qui a tutta una fenomenologia del bambino assente, dall’annegato al figlio mancato o possibile che avrebbe compiuto l’opera dell’eros, nonché la cura della dimora e dei suoi lari, gli antenati che la abitano in attesa:
“Il nostro bambino s’era perduto a primavera/ nel liquore silenzioso un pomeriggio. /chissà come chiamava il fiume, e il fiume lo teneva / Chissà come rideva quando rideva.” “Il figlio nostro che avrei chiamato Lucio.”
Quello che il compagno al mattino avrebbe posato sul cuscino a lato del suo capo, il bambino immaginario, attorno a cui costruire un nido, un rifugio. E che costituisce il destinatario ideale dell’intera liturgia messa in opera, a partire dalle cantilene infantili di inizio testo che riassumono la funzione della bugia poetica come farmaco contro il vuoto e la finitudine dell’esistenza. Una funzione che si condensa, dall’infanzia del mondo, nell’atto del battesimo delle cose, in una trance e stupore primordiale, in cui il rumore di fondo, il suono diffuso del travaglio della natura, giunge all’orecchio della poeta per farsi voce e parola. Innescando nella carne del mondo quella crepa madre da cui scaturisce tutta la poesia, quel taglio inarcato che si fa orizzonte del visibile (Riss/Umriss) unendo cielo e terra, i divini e i mortali (Heidegger). Ferita che si disegna sulle labbra di chi parla e non rimargina, se non per raccogliersi in un bacio da cui poi sboccia la comunione di corpi ed anime, la cura della casa ornata da “un cerchio di parole nel giardino”.
Così si attraversa tutta l’intricata serie di rimandi di quest’opera, il reticolo di rapporti che uniscono “i morti di tutte le specie” ai viventi e morituri. E che nel continuo parallelismo di testo e territorio saldano l’immaginario al simbolico, tentando di esorcizzare “l’innominabile attuale” (Calasso) in questa articolata liturgia dell’esserci, in vista della morte individuale e financo di una possibile estinzione della specie. Fra il “lustrale lavacro” dell’inizio e l’evocazione del diluvio per una palingenesi finale della terra madre. Ma all’esondazione dell’acqua, lacuna del possibile, uno dei temi prominenti di questa raccolta, fa riscontro quella del verso, dai limiti abituali della lirica, a lei congeniali, al terreno accidentato della prosa ritmica, in una esplorazione che segna una svolta nella carriera dell’autrice. Un esperimento rischioso ma carico di promesse.
[1] Vedi il mio “Eros e retorica. Nota sulla poesia di Silvia Secco”, Poetarum Silva, 23/04/2019.